📺 Disponibile su Netflix
Lo confesso, senza esitare: sono dipendente dalle serie poliziesche. Può essere un procedural, un thriller cupo, può avere quel detective tormentato che non sorride mai e mangia solo panini stantii davanti a una bacheca piena di foto collegate da fili rossi. Io ci sono sempre. Quindi, quando ho visto che Netflix stava per lanciare “Dept. Q”, adattamento dei romanzi danesi di Jussi Adler-Olsen, non ho avuto dubbi. Ciliegina sulla torta? È ambientata nella mia amatissima Edimburgo. Cielo grigio, architettura gotica, ferite emotive. Mi ci butto a capofitto.
La trama
Il detective Carl Mørck (Matthew Goode) ha il volto segnato da chi ha visto troppo. Dopo una sparatoria finita male, con un collega ucciso e un altro paralizzato, viene relegato in un nuovo reparto della polizia: il Department Q, specializzato in cold case. Un seminterrato dimenticato da Dio. Ma è lì che incontra Akram, rifugiato siriano dallo sguardo intelligente, e Rose, investigatrice con un passato fragile quanto il suo talento. Insieme, si buttano in un caso archiviato anni prima. Uno solo. Ma profondo, oscuro, e pieno di ferite da riaprire.
Regia e stile
La regia è gelida, chirurgica. I tagli sono lenti, i silenzi parlano più dei dialoghi. C’è quell’estetica da noir psicologico, come un incrocio tra “Mindhunter” e “Broadchurch”, ma con più umidità. Edimburgo diventa un personaggio a sé: grigia, severa, malinconica come un ricordo che non smette di pesare. La regia non ha fretta. Ti chiede di restare, di ascoltare. E questo, a volte, è tanto un pregio quanto un limite.
I punti deboli
La narrazione, seppur elegante e atmosferica, a volte si trascina. Ci sono momenti in cui volevo urlare: “Forza ragazzi, là fuori ci sono altri casi da risolvere!”. Il fatto che tutta la stagione ruoti attorno a un unico caso offre profondità, certo, ma chi ama il genere di solito si aspetta più ritmo. Avrei voluto vedere almeno un altro caso, un’altra indagine, qualcosa in più. Qui si affonda. Ma io, ogni tanto, volevo anche nuotare.
Ciò che mi ha colpita
I personaggi. Soprattutto Akram, con la sua storia mai raccontata fino in fondo, che ti costringe a guardare oltre il cliché. E poi l’atmosfera. Gli sguardi. Le cose non dette. È una serie che non ti invita a risolvere, ma a sentire. Mi è piaciuto anche il contrasto tra la freddezza quasi anaffettiva di Carl e l’umanità sofferta degli altri membri del team. Lì dentro c’è dolore vero. Carne viva.
La mia esperienza
Amo vedere casi intricati che si srotolano lentamente, e c’è qualcosa di confortante nel seguire qualcuno che cerca la verità anche quando tutto sembra perduto. Le serie poliziesche mi danno l’illusione che con logica e pazienza tutto possa essere capito. Non è vero, ma funziona.
Guardare “Dept. Q” è stato come ascoltare una storia sussurrata da qualcuno che ha vissuto troppo e non ha più fretta. In certi momenti ho lottato contro la noia, sì. Ma quando la trama prende ritmo, mi sono ritrovata a trattenere il respiro. Alla fine, volevo sapere di più. Non solo del caso, ma delle persone. Volevo vedere crescere quel reparto, entrare in altri archivi, perdermi in altri labirinti emotivi. E mi è mancato quel seminterrato umido, e Rose con i suoi post-it colorati come se stesse cercando di rimettere insieme il mondo.
Il verdetto
Dept. Q non è una serie per chi cerca azione continua o colpi di scena facili. È per chi vuole ascoltare il silenzio, seguire l’ombra, entrare nella mente e nelle ferite di chi cerca giustizia. Ha i suoi difetti, certo. Ma offre una profondità rara. Se amate i thriller psicologici con l’anima, questa serie merita il vostro tempo.
E voi? L’avete vista? Anch’io, alla fine, ho desiderato abbracciare Carl. Ma solo se lo accetta.


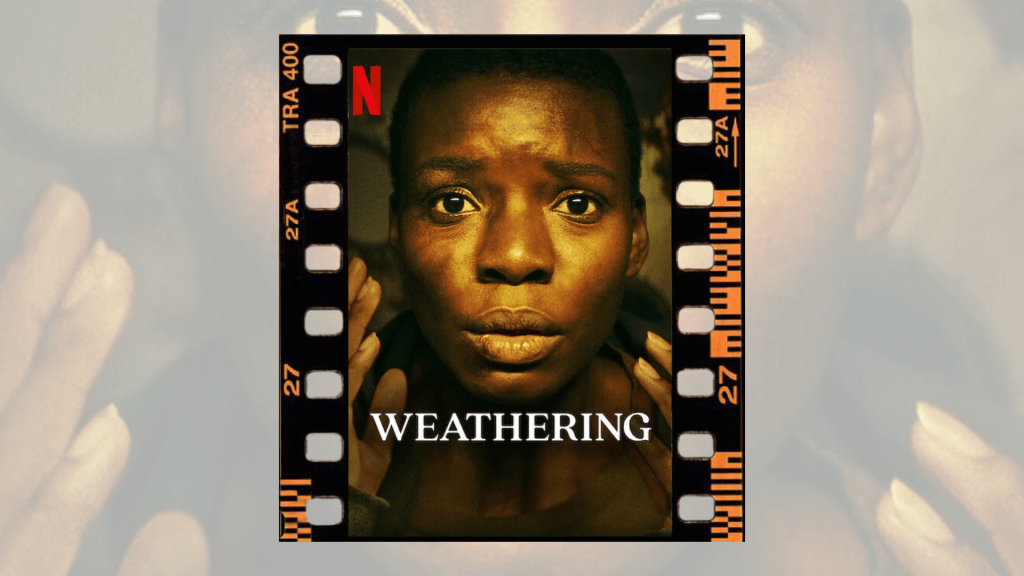

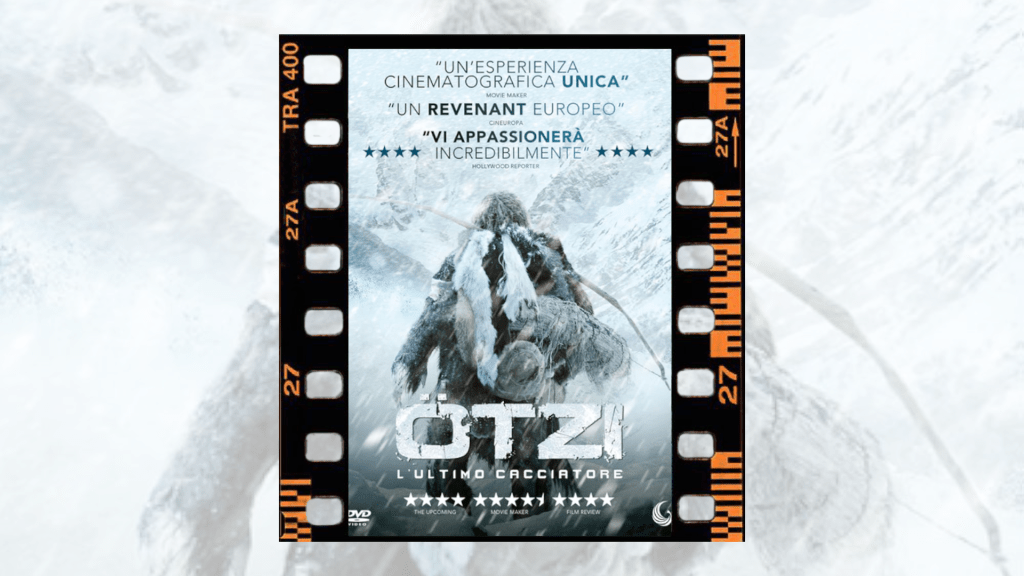
Scrivi una risposta a marisa salabelle Cancella risposta